Il Regno segreto – mostra al museo MAN di Nuoro
Una mostra post-coloniale con un esito coloniale
collettivo Filosofia de Logu
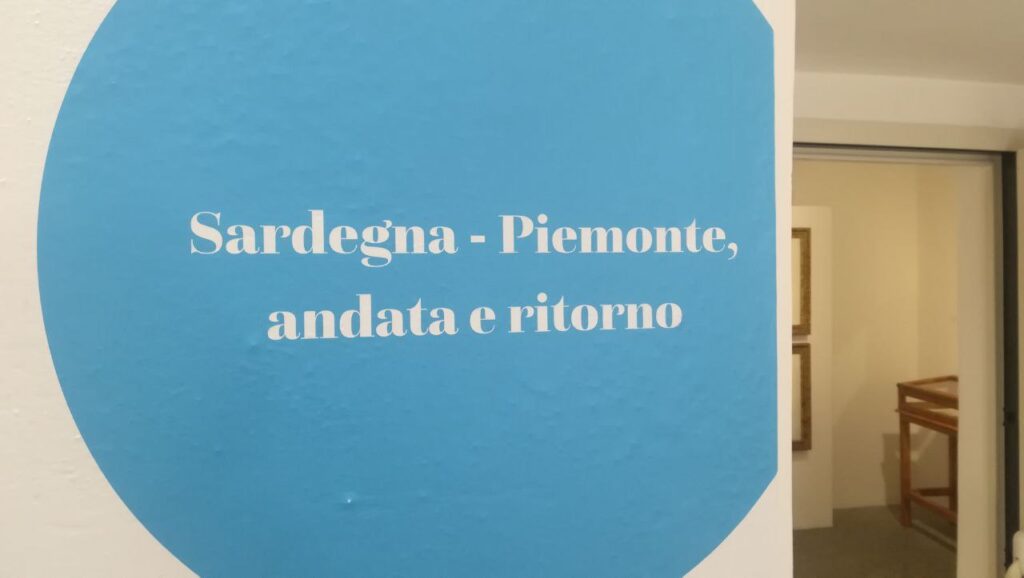
In occasione del trecentesimo anniversario della cessione ai Savoia del Regno di Sardegna (1720), il Museo MAN di Nuoro ha proposto un allestimento dedicato ai rapporti tra Piemonte e Sardegna nell’arco di tre secoli. Il titolo della mostra è “Il regno segreto. Sardegna-Piemonte: una visione postcoloniale” (in esposizione dal 29 maggio al 15 novembre 2020). Nella trattazione che segue si proverà a verificare se e quanto il risultato ottenuto sia efficace e in generale ad analizzare gli elementi discorsivi e ideologici posti a giustificazione dell’operazione o sottesi all’allestimento.
Il titolo dell’allestimento è già una dichiarazione d’intenti. Il senso della sua articolazione concreta, disposta su tre piani, è affidato alle didascalie che accompagnano la invero scarna esposizione di memorabilia, mappe e fotografie. Il catalogo della mostra, a sua volta, ne illustra contenuti e obiettivi, con gli interventi del direttore del MAN Luigi Fassi e del curatore Luca Scarlini, avvalendosi anche di apporti esterni. Per scelta esplicita del curatore l’esposizione non ha un filo conduttore cronologico né tematico. I dipinti del Graneri e la cartografia della Sardegna di epoca moderna (prima sezione, piano terra) potrebbero far pensare inizialmente a un percorso orientato alla ricostruzione del rapporto complesso tra due territori eterogenei per geografia e clima, per storia, cultura, dinamiche sociali. Tuttavia questo possibile approccio viene subito frustrato sia dal numero esiguo dei documenti esposti, sia dalla rinuncia programmatica (e realizzata) a fornire una chiave di lettura complessiva. Le restanti sezioni dell’allestimento diventano ben presto una giustapposizione di elementi eterogenei, svincolati tra loro, con salti cronologici e logici impossibili da comprendere per un visitatore ignaro e che deludono il visitatore informato.
Per quanto il curatore Luca Scarlini dichiari non esserci alcun pregiudizio e alcun intento ricostruttivo, è però inevitabile che fin dalla sua presentazione la mostra abbia invece un senso e una cornice interpretativa da proporre. Semplicemente, essi vengono lasciati alle suggestioni ricavabili dall’allestimento. Il titolo stesso della mostra, del resto, ha – o avrebbe – un suo significato piuttosto preciso, facendo riferimento agli studi post-coloniali.
Su quest’aspetto, sia il direttore del MAN Luigi Fassi sia il curatore Luca Scarlini spendono qualche spiegazione nei loro saggi contenuti nel catalogo.
Fassi, nella sua presentazione della mostra, intitolata Zone di contatto. Una visione postcoloniale: le ragioni di un termine, scrive:
“Il dibattito internazionale inaugurato dagli studi postcoloniali […] ha consentito di esaminare i legami storici e le differenze fra diversi luoghi e differenti culture, rivitalizzando un lavoro comparativo e permettendo lo sviluppo di spazi di studio dedicati a esperienze artistiche e culturali lontane dai canoni tradizionali della storia europea continentale.”
Ora, questa è una definizione di studi post-coloniali come minimo parziale. Gli studi post-coloniali, dai tempi di Fanon e Said e poi con i vari Bhabha, Spivak e via elencando, si sono occupati di individuare le relazioni di dominio e i rapporti di forza anche nella stessa costruzione delle identità dei colonizzati. Hanno decostruito la mitologia identitaria assemblata dai dominanti per giustificare e legittimare il loro dominio. Hanno problematizzato i concetti su cui si è basato il colonialismo europeo, a partire dal senso di superiorità civile e culturale (razziale). Hanno rimesso in discussione paradigmi politici e narrazioni istituzionali. Hanno fatto emergere i nessi tra condizione culturale e rapporti di forza economici nonché le reciproche connessioni tra le rivendicazioni sociali, quelle di genere e quelle di tutte le minoranze minorizzate e/o oppresse, analizzandone cause, dinamiche, meccanismi relazionali, esiti. In definitiva, qualcosa di radicalmente diverso, per non dire di opposto, da ciò che sembra ispirare la mostra in esame.
Un altro passaggio poco convincente della sua presentazione è quello in cui accenna a “…l’ininterrotto movimento di persone, oggetti e idee che ha cambiato il destino delle due regioni…”. Chiamare in causa un fenomeno storico (l’ininterrotto movimento di persone) senza contestualizzarlo, senza situarlo, senza precisarne limiti temporali, dimensioni, cause ed effetti lo rende un’astrazione anodina. Va poi segnalato – per l’ennesima volta – un uso del termine “regione” del tutto inappropriato. Sardegna e Piemonte nel Settecento non erano “regioni italiane” che per qualche accidente storico entrarono in contatto politico. Si trattava di entità storiche molto diverse, che per questioni di equilibri geo-politici si ritrovarono a coesistere sotto un medesimo sovrano. Sovrano del Regno di Sardegna (non “regione”, né altro), incidentalmente anche Principe del Piemonte (anche qui, il termine “regione” è del tutto improprio, specie in senso storico). Si guarda dunque a vicende, fatti e processi del passato attraverso una lente anacronistica, completamente focalizzata sul nostro presente. Come tale, distorsiva dell’oggetto osservato.
Da segnalare, ancora, un altro passaggio della presentazione di Fassi, perché mi sembra anch’esso indicativo di una certa confusione concettuale e teorica:
“Se la relazione identitaria [?] tra Sardegna e Piemonte è caratterizzata da un rapporto storico tra dominanti e dominati, la vastità di storie di creazione e innovazione culturale narrate da Il regno segreto rivela come le identità sociali, da entrambi i lati dei due poli, siano state costruite nel corso del tempo e non rigidamente predeterminate [?], instabili e antagonistiche, ma anche costantemente fluide, ibride, transnazionali.”
Il “rapporto storico tra dominanti e dominati” non è un aspetto secondario, che può essere lasciato al margine del discorso, specie se esso si basa su un approccio post-coloniale. La Sardegna e il Piemonte non sono entità a-storiche e astratte: da qui bisognerebbe partire. Invece in questa presentazione scompaiono tutte le articolazioni sociali e tutti i processi storici, le differenze concrete, le stesse masse popolari. Di quale Sardegna si parla? E di quale Piemonte? Della Sardegna delle élite politiche e intellettuali o della Sardegna popolare? E di quale periodo? Prima o dopo la Rivoluzione? E di quale Piemonte si tratta? Di quello della corte sabauda e della classe dominante? Del Piemonte di Torino o di quello delle sue regioni storiche, delle valli, delle montagne? Se non si tiene conto dell’estrema articolazione delle vicende concrete peculiari dei due territori, presi per sé o nei rapporti reciproci, si fa un’operazione che suona fondamentalmente ideologica, teoricamente debole e incoerente col suo stesso titolo.
Non aiuta a capire di più il saggio introduttivo di Luca Scarlini, Il regno segreto. Sardegna-Piemonte: una visione postcoloniale. Un’introduzione. A mo’ di giustificazione per la scelta del tema proposto, vi si fa riferimento a una presunta vis antisabauda largamente presente in Sardegna, senza però alcuna contestualizzazione o puntualizzazione. Di cosa si parla? A chi sarebbe riferibile? Non certo all’ambito intellettuale e istituzionale sardo, che anzi da anni mostra un atteggiamento tutto sommato acquiescente o addirittura partecipe alla ventata politico-culturale neo-risorgimentalista e sciovinista che domina in Italia (almeno) dalla presidenza Ciampi in qua (ma con prodromi che innervano tutta la cosiddetta “seconda repubblica” e radici ancora più profonde). Le istituzioni culturali nell’isola, dalle università alle soprintendenze, sono vigili custodi di una subalternità storica e politica costantemente pretesa, regolarmente ottenuta e ostinatamente certificata. Una subalternità che non può essere messa in discussione nemmeno dagli organi politici e amministrativi legittimamente in carica, come dimostrano le censure verso le amministrazioni comunali intervenute sull’odonomastica locale. In proposito sarà sufficiente ricordare che il più feroce rappresentante di questa attività di censura odonomastica, il professor Bruno Billeci, già Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, è stato recentemente nominato responsabile dei musei statali sardi. Tuttavia sarebbe stato anche accettabile un allestimento politicamente orientato, un’ipotesi ricostruttiva che rispondesse all’ostilità anti-sabauda diffusa; a patto di essere realizzato in modo rigoroso, ben dotato di documenti e testimonianze, coerentemente organizzato. Una scelta che, se dichiarata e opportunamente argomentata, sarebbe stata sì opinabile ma legittima e intellettualmente onesta. Chiaramente, non avrebbe avuto nulla a che fare con gli studi post-coloniali; ma possiamo immaginare che, in tal caso, anche il titolo sarebbe stato diverso. Nella disamina di Scarlini, invece, alla contestazione della vis polemica anti-sabauda non viene fornita una risposta esplicita e adeguatamente articolata. Vengono anzi estromessi dalla trattazione gli elementi decisivi della relazione storica tra Sardegna e Piemonte. È possibile che manchi una conoscenza approfondita di tale relazione storica, dei suoi sviluppi e dei suoi risvolti, come induce a sospettare l’equivoco relativo alla coincidenza tra la figura storica di Giovanni Battista Lorenzo Bogino, ministro per gli affari sardi tra 1759 e 1773, e il termine su buginu (il boia). Un equivoco ancora presente nel senso comune di molti sardi, almeno di quelli che si interessano di temi storici, ma non degno di un allestimento museale di queste pretese.
Un altro passaggio singolarmente significativo del saggio introduttivo di Scarlini è quello in cui si afferma che “…la Sardegna ha costituito per il Piemonte un deposito di suggestioni esotiche…” (pag. 16). Tale affermazione, da sola, basterebbe a smentire e ribaltare il senso presuntamente post-coloniale della mostra. Infatti è proprio qui che emerge uno dei nodi della questione. Un territorio dominato, reso subalterno e minorizzato culturalmente, ha fatto da “deposito di suggestioni esotiche” per il territorio dominante e la relativa classe egemone. La lettura post-coloniale metterebbe in evidenza proprio questo rapporto, problematizzandolo, criticandone premesse, effetti, conseguenze di lungo periodo. Invece la mostra sembra mettere questo problema – ossia IL problema – in secondo piano, facendone un accidente storico tutto sommato neutro, semplicemente dato.
Nemmeno gli altri interventi presenti nel catalogo sciolgono il nodo e diradano i dubbi. Anche in questo caso manca un preciso filo conduttore e i saggi proposti non sembrano risuonare uno con l’altro, non contribuiscono dunque alla costruzione di un senso complessivo, intellegibile e coerente dell’intera operazione. Senza voler fare una recensione particolareggiata di tutti i testi, basterà segnalare alcuni passaggi discorsivi e contenutistici significativi per la propria problematicità e degni di qualche riflessione.
Nel saggio di Luciano Marrocu, dedicato alla ben nota vicenda della Carte d’Arborea, essa viene presentata come un “grottesco… atto di indipendenza dei sardi”. Affermazione notevole, dato che al contrario quell’operazione aveva come scopo la legittimazione della classe intellettuale e in generale della classe dominante sarda nell’establishment sabaudo. Verrebbe da pensare che Marrocu, che difficilmente può ingannarsi circa fatti e personaggi da lui a lungo studiati, abbia però una strana idea degli indipendentisti sardi, delle loro ragioni e dei loro obiettivi. Marrocu conclude giustamente che la vicenda dei clamorosi falsi gettò discredito sia sull’ambito culturale sardo sia su quello torinese. Il che tuttavia non dovrebbe sorprendere lo storico, ben conscio di quanto fossero mediocri entrambi. Torino non era allora una grande capitale culturale europea; gli studi storici e filologici, benché tenuti in una certa considerazione, erano spesso un’occupazione dilettantesca cui si dedicavano i figli cadetti delle famiglie altolocate, gli ecclesiastici, i quadri amministrativi intermedi. Si trattava il più delle volte della ricerca di “glorie patrie”, condotta con un gusto squisitamente antiquario, più che un lavoro basato sul metodo scientifico e sull’acribia euristica. Anche quando la ricerca era meno viziata da questa debolezza di impostazione doveva comunque fare i conti con un controllo piuttosto rigido da parte dell’occhiuta censura sabauda. Il problema è che, se si esula dal contesto storico-culturale in cui le Carte furono prodotte e pubblicate, non se ne comprendono la natura e il significato. Pur essendo dei falsi, infatti, esse sono anche, a buon diritto, un prezioso documento storico. Non nel senso che a esse dava chi le produsse o le prese per buone, o chi ne decretò la falsità, ma nel senso che si tratta di una testimonianza che ci illumina su un periodo storico e sulle aspirazioni di un’intera classe intellettuale, a sua volta interprete di esigenze e obiettivi politici più ampi. E proprio qui subentrerebbe proficuamente un approccio post-coloniale all’intera faccenda. Approccio che tuttavia, se applicato, offrirebbe un quadro interpretativo radicalmente diverso da quello esposto in questa mostra. Da una parte una classe intellettuale debilitata, conformista e conservatrice che aveva bisogno di legittimarsi dentro una compagine statale il cui baricentro era ormai definitivamente spostato a Torino (ben prima della funesta Fusione perfetta). Dall’altra la classe intellettuale e politica piemontese, a sua volta provinciale e tutt’altro che “aperta”, ma che faceva da punto di riferimento alla sua omologa sarda. Il rapporto di forza e di dominio, in termini culturali non meno che in termini politici ed economici, entra prepotentemente in gioco e spiega molto di questi fatti altrimenti stupefacenti. Non si trattò dunque di un colpo di testa isolato di qualche imbroglione, o in ogni caso questo elemento fu circostanziale e accessorio.
Lo spazio dedicato alla stagione delle Carte d’Arborea nell’allestimento della mostra non è piccolo, in proporzione alle sue dimensioni, ma non è presentato adeguatamente, né precisato nel contesto a cui fa riferimento, alle vicende storiche che ne sono lo sfondo e la premessa. I falsi bronzi nuragici esposti non chiariscono nulla e anzi rischiano di ingenerare un equivoco sulla loro stessa autenticità. Il saggio di Luciano Marrocu, pure interessante di suo, risulta a sua volta disconnesso sia dagli intenti annunciati della mostra sia dall’allestimento concreto della medesima, non contribuendo a una sua maggiore comprensibilità.
Un breve accenno va fatto anche al testo proposto da Marcello Fois che, in quanto autore nuorese, fa un po’ le veci del padrone di casa. Si tratta di un saggio in cui Fois riepiloga cose già scritte e dichiarate più volte, sulla questione degli stereotipi culturali e sulle debolezze della rappresentazione di sé dei sardi. Si intitola Un senso di sé. Le “idiozie” prodotte da un “malinteso senso di sé” denotano, secondo Fois, la produzione culturale isolana e il senso comune dei sardi contemporanei. La sua è un’analisi severa, che mette in rilievo alcuni fenomeni sociologici reali, ma li inquadra dentro una cornice antropologica a sua volta colpevolizzante omettendone cause storiche, diffusione e motivazioni. Il peso dei fatti politici e della storia stessa scompare, in questa disamina. Scompare anche il ruolo degli intellettuali e specialmente di quelli istituzionali e/o organici all’apparato egemone. Parrebbe insomma che i sardi siano maledetti da una tara connaturata nel loro stesso ethnos.
Occorre per altro segnalare uno svarione storico, sorprendentemente non eliminato nemmeno in fase di correzione delle bozze. Fois ad un certo punto accenna all’”annessione al Regno Piemontese” della Sardegna, dimenticando che non ci fu alcuna annessione e che il Regno in questione era quello “di Sardegna” (non essendo mai storicamente esistito alcun Regno di Piemonte). Potrebbe anche trattarsi di un lapsus, questo sì interessante in un’ottica di analisi post-coloniale.
Sul resto della trattazione di Fois è come minimo doveroso soffermarsi su un aspetto da lui stesso sollevato, quello della riduzione della cultura sarda a mera rappresentazione folkloristica. È certamente una questione rilevante. E tuttavia, al contrario di quanto emerge dalla lettura del saggio, la folklorizzazione della cultura popolare sarda non è una scelta deliberata e auto-promozionale, sia pure di cattivo gusto, dei sardi stessi, ma piuttosto l’effetto di una vicenda di colonizzazione culturale, di deprivazione storica e linguistica, di minorizzazione. In fondo, è proprio ciò che dovrebbe problematizzare e discutere un approccio post-coloniale. La mancanza di una “memoria collettiva” strutturata (posto che sia lecito parlare di “memoria collettiva”), una memoria che non sia megalomane né, viceversa, depressa, non è una “colpa” dei sardi, ma anch’essa un risultato storico dovuto a cause piuttosto riconoscibili, comunque suscettibili di essere oggetto di ricerca e di studio. Lecito e anzi doveroso auspicare che ricerca e studio vengano irrobustiti e ampliati in tutti gli ambiti coinvolti. Meno lecito ridurre la questione a una sorta di generica invettiva anti-sarda, non solo ingiustificata ma anche improduttiva.
Come si vede anche tramite questi esempi, nemmeno il catalogo della mostra aiuta a diradare le riserve che essa suscita. L’allestimento stesso risulta, nel complesso, non solo e non tanto poco efficace, ma prima di tutto privo di un senso compiuto. Le didascalie poste a corredo esplicativo dell’esposizione sono insufficienti a fornire elementi di comprensione. La lettura generale che esse veicolano, fin dall’inizio, è che i rapporti tra Sardegna e Piemonte meritino di essere esplorati in quanto “episodio significativo delle italiche vicende” (come recita quella di apertura). È una cornice interpretativa molto debole, anacronistica e troppo generica. In alcuni casi le didascalie sembrano mal ancorate a ciò che poi è presentato alla visione dei visitatori; in altri offrono chiavi interpretative a dir poco fuorvianti. Esempio clamoroso, in quest’ultimo senso, la chiamata in causa di Antonio Gramsci come testimone e rappresentante di presunti rapporti proficui tra Sardegna e Piemonte. Una forzatura, anche nel migliore dei casi, profondamente scorretta, sia nei confronti del visitatore ignaro, sia – è anche doloroso sottolinearlo – di Nino Gramsci medesimo. Per rendersi conto della profondità dell’equivoco basterebbe leggere le non poche righe dedicate da Gramsci ai Savoia e alla relazione tra Piemonte e Sardegna. Il richiamo della sua figura in questi termini e in tale contesto suona meramente strumentale e alquanto falsificante.
Nell’insieme, dunque, la mostra assomma criticità e debolezze che da un lato tradiscono le sue stesse intenzioni, da un altro purtroppo contribuiscono ad aggrovigliare ulteriormente la matassa degli equivoci e delle misconoscenze storiche relative alla Sardegna. Pare dunque più che altro un’occasione persa di riflettere su un passaggio storico decisivo – il passaggio della corona sarda in capo alla dinastia sabauda – e sulle sue conseguenze fino ai giorni nostri. Probabilmente sarebbe stato il caso di meditare meglio sugli obiettivi e sulle modalità di un’operazione del genere e sarebbe stato utile coinvolgere di più e con maggiore profondità i vari ambiti di studio connessi alle tematiche evocate. L’auspicio è che prima o poi si possa davvero realizzare un allestimento votato a un approccio post-coloniale, magari non solo e non tanto relativamente ai rapporti tra Sardegna e Piemonte, quanto piuttosto all’intera epoca contemporanea sarda. Imparare dagli errori fatti in questa occasione potrebbe servire ad attribuire alla mostra nuorese se non altro tale involontario merito.



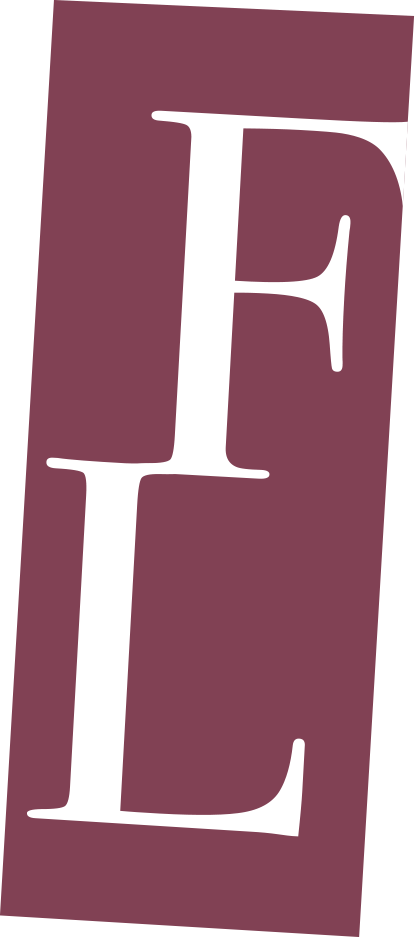



5 commenti
Francesco Masia
Mi ero regalato questa mostra per il compleanno.
Avete dato parole, anche misurate (non siete nemmeno scaduti a citare le origini del direttore e del curatore, chapeau), al mio imbarazzato sconcerto. Uno schiaffo alla Sardegna, nel suo cuore: che Angioy (a nome di tutti) li perdoni.
Augurarsi che la lezione serva è giusto, speriamo quindi che se ne parli.
Grazie.
antonio giovanni frogheri
una mostra BLASFEMA- DELINQUENZIALE- COME NEL CLASSICO STILE SABAUDO. Fortunatamente “i più” non sono andati a vederla.
Walter
Quando si dice, “leggergli la vita”. Dai poco “armati” sull’argomento come me, grazie al Collettivo.
Alfonso Stiglitz
Non ho visto la mostra e non ho letto il catalogo, quindi intervengo solo sulla lettura critica che ne ha dato il collettivo Filosofia de Logu, attenendomi agli aspetti generali e non a quelli specifici dell’allestimento [sugli allestimenti e sul concetto di allestimento sarebbero necessarie riflessioni decisamente più articolate e difficili da sintetizzare in un breve commento]. Non ho la forza di fare un discorso complessivo, ma solo alcuni spunti.
Condivido molto di quanto scritto ma con alcune perplessità (o meglio sensazioni disagevoli) che potrebbero derivare da mie incomprensioni, ovviamente; mi sembra, infatti, che l’analisi critica indugi un po’ sulle vecchie posizioni resistenziali, rilette alla luce del postcolonialismo. In altre parole la sensazione è quello dell’annosa dicotomia dominatori/dominati, nella vecchia dicotomia (Nord/sud; primo/terzo mondo ecc.) intesi come categorie assolute, dalla quale restano esclusi quei fenomeni di ibridazione (bruttissima parola che non uso), parte fondante del discorso postcoloniale (Bahba), nel quale il processo riguarda il ‘nativo’ (altro termine orrendo) ma anche il potere coloniale. Fenomeni che mettono in campo quei processi per i quali l’identità non è un «riflesso di tratti etnici e culturali già dati, ma una negoziazione complessa e continua che conferisce autorità a ibridi culturali nati in momenti di trasformazione storica e sociale» (Bahba): che è quello che permette di superare il vecchio resistenzialismo e ridare voce a quella parte di storia che sostanzialmente è scomparsa sia nella narrativa del cd. potere sia in quella del cd contropotere.
Il rapporto Dominatori/dominati che ho trovato nell’analisi che avete fatto mi sembra ridotto al dominatore che impone la propria visione e al corpo dirigente e intellettuale locale, imbelle e collaborazionista che se ne fa portavoce. In questo vedo anche l’assenza del buon vecchio Gramsci e delle sue riflessioni sull’egemonia e sui subalterni.
Mi sembra anche indicativa la serie di domande in sé corretta: “Di quale Sardegna si parla? E di quale Piemonte? Della Sardegna delle élite politiche e intellettuali o della Sardegna popolare? E di quale periodo? Prima o dopo la Rivoluzione? E di quale Piemonte si tratta? Di quello della corte sabauda e della classe dominante? Del Piemonte di Torino o di quello delle sue regioni storiche, delle valli, delle montagne?”.
Ma se la scomponiamo vediamo che per il Piemonte si chiede giustamente di quale Piemonte (regioni storiche, valli, montagne), per la Sardegna, invece, l’unica scelta è quella di élite-popolo oppure periodo storico: una visione francamente poco conseguente alla proposta post-coloniale; anche per la Sardegna potremmo chiederci quale Sardegna (regioni storiche, valli, montagne). Se no torniamo a una visione essenzialista-resistenzialista della nostra storia.
Infine, e smetto, il problema della Sardegna terra esotica: lo era certamente, e non solamente per i Piemontesi, ma per tutti gli europei e lo è ancora. Lo è ancora non solo per una visione esterna ma perché è diventato il metro ideologico con il quale noi sardi ci proponiamo all’esterno, dai filmati pubblicitari proposti dalla Regione e altri enti, a quelli dei gruppi culturali ecc. È circoscrivibile solo in un rapporto dominatore/dominato? Quindi il dominato è inestricabilmente incapace di esprimere una propria visione del mondo, ancorché folkloristica (nel senso deteriore del termine), o auto esoticizzante?
E qui, giusto per fare un salto, come inserire l’esotismo africano di cui furono protagonisti molti dei nostri artisti più quotati e più ‘identitari’ (ammesso che questo termine abbia un senso), Biasi e altri, con i loro splendidi paesaggi africani esotici, trasmessi nelle riviste, nei giornali, nei manifesti, pienamente e consapevolmente partecipi del colonialismo fascista in Africa. Noi terra (auto)esotica che esotizza l’altro. Anche questo difficilmente leggibile se ci fermiamo alle visioni dicotomiche (noi/loro, dominatori/dominati, Nord/Sud) ecc.
Confuse annotazioni, per dire che con il testo del collettivo Filosofia de Logu sono “totalmente d’accordo al 50%” (cit.)
Omar Onnis
Grazie, Alfonso, per il commento argomentato. Provo a rispondere io punto per punto, senza la pretesa di esaurire le questioni (sono tra quelli che hanno visitato la mostra).
AS -Condivido molto di quanto scritto ma con alcune perplessità (o meglio sensazioni disagevoli) che potrebbero derivare da mie incomprensioni, ovviamente; mi sembra, infatti, che l’analisi critica indugi un po’ sulle vecchie posizioni resistenziali, rilette alla luce del postcolonialismo. In altre parole la sensazione è quello dell’annosa dicotomia dominatori/dominati, nella vecchia dicotomia (Nord/sud; primo/terzo mondo ecc.) intesi come categorie assolute, dalla quale restano esclusi quei fenomeni di ibridazione (bruttissima parola che non uso), parte fondante del discorso postcoloniale (Bahba), nel quale il processo riguarda il ‘nativo’ (altro termine orrendo) ma anche il potere coloniale. Fenomeni che mettono in campo quei processi per i quali l’identità non è un «riflesso di tratti etnici e culturali già dati, ma una negoziazione complessa e continua che conferisce autorità a ibridi culturali nati in momenti di trasformazione storica e sociale» (Bahba): che è quello che permette di superare il vecchio resistenzialismo e ridare voce a quella parte di storia che sostanzialmente è scomparsa sia nella narrativa del cd. potere sia in quella del cd contropotere.
– Osservazione pertinente. Tuttavia lo schematismo deriva da quello proposto dalla mostra stessa, che pur dichiarando – nelle intenzioni di chi l’ha curata – di voler appunto “mostrare” il processo di negoziazione e di ibridazione (usiamolo pure, questo termine; c’è di peggio), in realtà non lo fa. Si limita giustapporre elementi eterogenei e non connessi, senza alcun reale tentativo di mettere in discussione la dicotomia schematica dominante/dominato, ma anzi evocandola anodinamente. Se fosse stata problematizzata in modo consono, l’esito sarebbe stato diverso e anche il nostro giudizio probabilmente sarebbe stato differente.
AS -Il rapporto Dominatori/dominati che ho trovato nell’analisi che avete fatto mi sembra ridotto al dominatore che impone la propria visione e al corpo dirigente e intellettuale locale, imbelle e collaborazionista che se ne fa portavoce. In questo vedo anche l’assenza del buon vecchio Gramsci e delle sue riflessioni sull’egemonia e sui subalterni.
– Il buon vecchio Gramsci è molto presente, in realtà, e aleggia su di noi. Sul rapporto tra Sardegna e Piemonte ha scritto parole abbastanza note, oltre che severe. Senza limitarci a seguirne pedissequamente le orme, possiamo anche solo ribadire, qui, che il problema della subalternità culturale della Sardegna ottocentesca e novecentesca e dell’adesione del “corpo dirigente e intellettuale locale” alla mitologia identitaria costruita sulla Sardegna e sui sardi è un problema complesso quanto profondo e sempre attuale. Sarebbe stato opportuno metterlo in luce, magari anche qui facendone emergere la dialettica non unidirezionale (nel caso la si fosse riscontrata). Invece tutto ciò manca completamente. Gramsci è chiamato in causa nella mostra stessa, ma in modo maldestro e persino imbarazzante, come riferito anche nella nostra analisi.
AS -Mi sembra anche indicativa la serie di domande in sé corretta: “Di quale Sardegna si parla? E di quale Piemonte? Della Sardegna delle élite politiche e intellettuali o della Sardegna popolare? E di quale periodo? Prima o dopo la Rivoluzione? E di quale Piemonte si tratta? Di quello della corte sabauda e della classe dominante? Del Piemonte di Torino o di quello delle sue regioni storiche, delle valli, delle montagne?”.
Ma se la scomponiamo vediamo che per il Piemonte si chiede giustamente di quale Piemonte (regioni storiche, valli, montagne), per la Sardegna, invece, l’unica scelta è quella di élite-popolo oppure periodo storico: una visione francamente poco conseguente alla proposta post-coloniale; anche per la Sardegna potremmo chiederci quale Sardegna (regioni storiche, valli, montagne). Se no torniamo a una visione essenzialista-resistenzialista della nostra storia.
– L’obiezione sarebbe corretta se l’elenco di domande fosse esaustivo. Non lo è. Si tratta di un elenco puramente indicativo di alcuni dei quesiti che la mostra e la sua presentazione nel catalogo sollevano. Quindi possiamo rassicurare sul fatto che non ci siamo adagiati su una visione resistenzialista-essenzialista della nostra storia. Ma del resto proprio la storia è la grande assente nella mostra del MAN.
AS -Infine, e smetto, il problema della Sardegna terra esotica: lo era certamente, e non solamente per i Piemontesi, ma per tutti gli europei e lo è ancora. Lo è ancora non solo per una visione esterna ma perché è diventato il metro ideologico con il quale noi sardi ci proponiamo all’esterno, dai filmati pubblicitari proposti dalla Regione e altri enti, a quelli dei gruppi culturali ecc. È circoscrivibile solo in un rapporto dominatore/dominato? Quindi il dominato è inestricabilmente incapace di esprimere una propria visione del mondo, ancorché folkloristica (nel senso deteriore del termine), o auto esoticizzante?
E qui, giusto per fare un salto, come inserire l’esotismo africano di cui furono protagonisti molti dei nostri artisti più quotati e più ‘identitari’ (ammesso che questo termine abbia un senso), Biasi e altri, con i loro splendidi paesaggi africani esotici, trasmessi nelle riviste, nei giornali, nei manifesti, pienamente e consapevolmente partecipi del colonialismo fascista in Africa. Noi terra (auto)esotica che esotizza l’altro. Anche questo difficilmente leggibile se ci fermiamo alle visioni dicotomiche (noi/loro, dominatori/dominati, Nord/Sud) ecc.
– Qui la replica viene spontanea. Chi sono questi “noi sardi” che assimilano e ripropongono la visione esotica dell’isola e di se stessi? Come si è generata questa visione, posto che sia davvero unanime e mai messa in discussione? Come e da chi è stata veicolata e imposta egemonicamente? E a quale scopo, se ve n’è uno o più d’uno? L’esotizzazione della Sardegna (“la nostra Patagonia”, scriveva Giulio Bechi nella prefazione all’ennesima edizione del suo Caccia grossa, nel 1914) è un fenomeno centrale nella nostra condizione storica subalterna. Fa parte integrante del mito identitario dentro il quale molti sardi si riconoscono. Si riconoscono passivamente. Fa parte – è vero – anche di una certa narrazione istituzionale e mediatica locale. Proprio su questo bisognerebbe porsi delle domande, non sciorinare certezze apodittiche (la colpa è dei sardi stessi, che amano raccontarsi così). In questo problema un ruolo notevole è rivestito dagli intellettuali sardi. Non da tutti, chiaramente, ma da molti, alcuni con grande visibilità nello spazio mediatico italiano. A loro volta sostenuti da autorevoli commentatori non sardi ma, a loro stesso dire, grandi conoscitori e amanti della Sardegna, che imperversano in tutti gli spazi comunicativi. Evito di fare un elenco di nomi. Qui stesso c’è uno dei temi centrali da affrontare con un coerente approccio post-coloniale. Peccato che non sia stato minimamente fatto nella mostra del MAN.
Quanto ai grandi artisti sardi del primo Novecento, la loro partecipazione alla costruzione di un immaginario dell’esotico, anche coloniale, fa parte della complessità dei fenomeni umani. Possiamo stupircene? E poi, chi era la loro committenza? A quale pubblico si rivolgevano? E sono davvero tutti uguali o ugualmente orientati? Il formarsi di un’idea esotica di noi stessi va per forza contro l’esotizzazione di altre popolazioni? Il discorso è affascinante, ma non è possibile affrontarlo in questa sede. In ogni caso, non v’è traccia della questione nell’allestimento del MAN, ed è un peccato.
Del resto, per trasporre la questione su un altro piano, oggi esiste un certo numero di sardi affascinati da tesi xenofobe e addirittura razziste, ostili ai migranti, convinti che ci si debba difendere dall’”invasione” e dalla “sostituzione etnica”. Sono passate al massimo due generazioni dalla nostra prima, vera emigrazione di massa, e non è un fenomeno estraneo anche ai sardi di oggi, ma sembra che questo trauma sia del tutto rimosso. Ci sarebbe da farsi delle domande anche su questo, e non limitarsi a dare per scontato che i sardi debbano andarsene dalla Sardegna per trovare fortuna e gloria (come lascia apertamente intendere la mostra). Le posizioni xenofobe e/o razziste dei sardi di oggi sono chiaramente pulsioni irriflesse, basate su alcune, potenti “idee senza parole”, generate dall’esposizione passiva alla sfera mediatica italiana. Sono insomma la conseguenza di una forte pressione egemonica, dentro i complicati processi sociali e culturali di questi decenni. Periodo in cui non si è (ancora?) formata una “grande narrazione” autonoma, un senso comune estraneo o magari ostile ai processi di acculturazione e minorizzazione culturale (pensiamo alla questione linguistica, tema determinante di cui nella mostra nuorese non si rinviene alcuna traccia), a loro volta paralleli e funzionali alla soggezione economica e politica dell’isola.
È tutto materiale molto interessante da sottoporre a studio e a vaglio intellettuale. Cosa che però la mostra del MAN non fa né si propone di fare, pur presentandosi in modo impegnativo come un’operazione di svelamento “post-coloniale”. Da qui la nostra perplessità sulla sua riuscita.
Ma mi sono dilungato fin troppo anche io. Nel caso andassi a vedere la mostra a Nuoro, accoglieremmo volentieri una tua valutazione. Siamo sempre aperti.